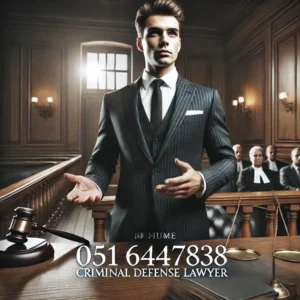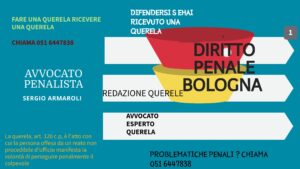INTERROGATORIO PRESSO POLIZIA GIUDIZIARIA DIFENSORE
L’interrogatorio presso la Polizia Giudiziaria in presenza del difensore è un momento fondamentale per la difesa dell’indagato o dell’imputato. Ecco alcuni punti chiave riguardo a questa procedura:
-
Handcuffs and gavel on laptop Diritto alla Presenza del Difensore
- L’indagato ha diritto ad essere assistito da un avvocato di fiducia o, in
mancanza, da un difensore d’ufficio.
- La Polizia Giudiziaria deve avvisare l’indagato del diritto di nominare un difensore prima dell’interrogatorio.
- L’interrogatorio non può iniziare prima che il difensore sia stato avvisato e abbia avuto il tempo necessario per intervenire.
-
MORTE IN INCIDENTE Garanzie per l’Indagato
- L’indagato deve essere informato della natura delle accuse e dei suoi diritti, tra cui il diritto al silenzio (art. 64 c.p.p.).
- Il difensore può intervenire per garantire che le domande siano formulate nel rispetto della legge e senza pressioni indebite.
- Se l’indagato si avvale della facoltà di non rispondere, il difensore può assicurarsi che ciò sia rispettato.
- Ruolo della Polizia Giudiziaria
MORTE IN INCIDENTE
- La Polizia Giudiziaria conduce l’interrogatorio sotto il coordinamento del Pubblico Ministero.
- Le domande devono riguardare i fatti oggetto dell’indagine e non possono essere suggestive o indurre risposte forzate.
- L’interrogatorio viene verbalizzato e il difensore può chiedere integrazioni o correzioni.
- Facoltà e Strategie del Difensore
- Può consigliare il proprio assistito se rispondere o meno alle domande.
- Può chiedere chiarimenti sulle domande formulate.
- Può far inserire dichiarazioni o osservazioni nel verbale.
- Conseguenze del Rifiuto di Rispondere
- L’indagato può sempre avvalersi della facoltà di non rispondere senza che ciò costituisca un’ammissione di colpevolezza.
- Tuttavia, il suo silenzio può essere valutato nel contesto probatorio complessivo.
INTERROGATORIO EFFETTUATO DAL PUBBLICO MINISTERO
L’interrogatorio condotto dal Pubblico Ministero (PM) è una fase cruciale del procedimento penale in Italia. Ecco i principali aspetti normativi e procedurali:
- Normativa di Riferimento
denunce querela bologna
- L’interrogatorio del Pubblico Ministero è regolato dagli articoli 64 e 65 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), che stabiliscono i diritti dell’indagato e le modalità della sua esecuzione.
- Si svolge nel rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio.
- Soggetti Coinvolti
- Indagato o imputato: la persona sottoposta a indagine o a processo.
- Pubblico Ministero: l’organo dell’accusa che conduce l’interrogatorio.
- Difensore: il legale dell’indagato, che deve essere preventivamente avvisato e può partecipare.
- Ufficiale di Polizia Giudiziaria (eventuale): può essere presente su delega del PM per verbalizzare.
- Modalità dell’Interrogatorio
- a) Obbligo di Avviso dei Diritti
Prima di iniziare l’interrogatorio, il PM deve informare l’indagato:
- Della natura dell’accusa e dei fatti contestati.
- Del diritto di nominare un difensore.
- Del diritto al silenzio (art. 64 c.p.p.) senza che questo possa essere considerato come un’ammissione di colpevolezza.
- b) Svolgimento dell’Interrogatorio
- Il PM pone domande per ottenere chiarimenti sui fatti e raccogliere elementi di prova.
- Le domande non possono essere suggestive o coercitive.
- Il difensore può intervenire, chiedere precisazioni o contestare modalità ritenute irregolari.
- L’interrogatorio è verbalizzato e può essere registrato.
- Differenza tra Interrogatorio in Fase di Indagini e in Dibattimento
| Fase | Caratteristiche |
| Interrogatorio durante le indagini preliminari | L’indagato non è obbligato a rispondere, e l’interrogatorio può essere richiesto dal PM o dallo stesso indagato per fornire la propria versione. |
| Interrogatorio in dibattimento | Se l’imputato ha scelto di sottoporsi all’interrogatorio, deve rispondere alle domande del PM, del giudice e del difensore. |
- Facoltà dell’Indagato
- Può scegliere di non rispondere o rispondere solo ad alcune domande.
- Può chiedere di essere interrogato per difendersi o chiarire la propria posizione.
- Può chiedere la presenza del proprio difensore, che può intervenire per tutelarlo.
- Conseguenze della Mancata Risposta
- Se l’indagato si avvale del diritto al silenzio, questo non può essere considerato prova di colpevolezza.
- Tuttavia, in sede di dibattimento, un eventuale silenzio su questioni rilevanti può essere valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Interrogatorio del Testimone o della Persona Informata sui Fatti
- Se il PM interroga un testimone, questi ha l’obbligo di rispondere in modo veritiero (pena il reato di falsa testimonianza, art. 372 c.p.).
- Se la persona interrogata risulta sospettata di un reato, il PM deve interrompere l’interrogatorio e garantirle le tutele previste per gli indagati.
- Nullità dell’Interrogatorio
L’interrogatorio può essere dichiarato nullo se:
- Non è stato garantito il diritto di assistenza legale.
- L’indagato non è stato informato dei suoi diritti fondamentali.
- Le risposte sono state ottenute con pressioni indebite o violazioni procedurali.
Conclusione
L’interrogatorio da parte del Pubblico Ministero è uno strumento investigativo importante, ma deve rispettare rigorose garanzie procedurali. Il difensore svolge un ruolo essenziale nel vigilare sulla regolarità dell’atto e nella tutela dell’indagato.
L’interrogatorio effettuato dal Pubblico Ministero (PM) è una fase importante delle indagini preliminari o del processo penale, disciplinata dal Codice di Procedura Penale (c.p.p.). Di seguito, vengono illustrati i principali aspetti relativi a questa procedura.
- Interrogatorio dell’Indagato da Parte del Pubblico Ministero
L’interrogatorio può essere svolto dal Pubblico Ministero sia nella fase delle indagini preliminari sia in sede processuale.
1.1. Finalità dell’Interrogatorio
L’interrogatorio ha lo scopo di:
- Consentire all’indagato di fornire la propria versione dei fatti.
- Accertare elementi utili per le indagini.
- Raccogliere eventuali dichiarazioni di confessione o giustificazione.
1.2. Diritti dell’Indagato
Prima dell’interrogatorio, il Pubblico Ministero deve informare l’indagato dei seguenti diritti (art. 64 c.p.p.):
- Diritto alla presenza del difensore: l’indagato deve essere assistito da un avvocato di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.
- Diritto al silenzio: l’indagato può decidere di non rispondere senza che ciò possa essere usato contro di lui.
- Diritto a non autoaccusarsi: l’indagato non può essere costretto a confessare.
- Diritto a essere informato dei fatti contestati.
Se questi diritti non vengono rispettati, le dichiarazioni rese dall’indagato possono essere inutilizzabili nel processo.
- Modalità dell’Interrogatorio
L’interrogatorio può avvenire spontaneamente o su convocazione del PM.
2.1. Convocazione e Notifica
- Il Pubblico Ministero può convocare l’indagato mediante invito a presentarsi, notificato dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria.
- Se l’indagato è in stato di custodia cautelare, l’interrogatorio avviene nel luogo di detenzione.
2.2. Svolgimento
- Il PM formula le domande direttamente all’indagato.
- Il difensore può assistere all’interrogatorio e chiedere integrazioni.
- Le dichiarazioni vengono verbalizzate e possono essere firmate dall’indagato.
Se l’interrogatorio riguarda reati gravi o se c’è il rischio di alterazione delle prove, il PM può videoregistrare l’interrogatorio per garantirne l’autenticità.
- Obbligo o Facoltà di Rispondere
- L’indagato non è obbligato a rispondere e può avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Se decide di rispondere, tutto ciò che afferma potrà essere utilizzato nel processo.
- Differenza tra Interrogatorio del PM e della Polizia Giudiziaria
| Aspetto | Interrogatorio della Polizia Giudiziaria | Interrogatorio del Pubblico Ministero |
| Autorità che lo conduce | Polizia Giudiziaria | Pubblico Ministero |
| Obbligo della presenza del difensore | Non sempre obbligatorio | Sempre obbligatorio |
| Finalità | Raccolta di informazioni per le indagini | Valutazione degli elementi probatori e preparazione dell’accusa |
| Effetto sulle dichiarazioni | Possono essere contestate nel processo | Dichiarazioni più rilevanti ai fini processuali |
- Rilevanza Processuale dell’Interrogatorio
Le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero:
- Possono essere utilizzate nel processo.
- Se contenenti elementi di autoaccusa, devono essere valutate con attenzione dal difensore.
- Se l’indagato cambia versione in aula, il PM può contestargli le dichiarazioni rese in precedenza.
- Strategie Difensive Durante l’Interrogatorio
Il difensore deve:
- Valutare se consigliare all’indagato di rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Assicurarsi che le domande siano poste nel rispetto della legge.
- Verificare che il verbale riporti fedelmente le dichiarazioni dell’indagato.
L’interrogatorio effettuato dal Pubblico Ministero (PM) è una fase importante delle indagini preliminari o del processo penale, disciplinata dal Codice di Procedura Penale (c.p.p.). Di seguito, vengono illustrati i principali aspetti relativi a questa procedura.
- Interrogatorio dell’Indagato da Parte del Pubblico Ministero
L’interrogatorio può essere svolto dal Pubblico Ministero sia nella fase delle indagini preliminari sia in sede processuale.
1.1. Finalità dell’Interrogatorio
L’interrogatorio ha lo scopo di:
- Consentire all’indagato di fornire la propria versione dei fatti.
- Accertare elementi utili per le indagini.
- Raccogliere eventuali dichiarazioni di confessione o giustificazione.
1.2. Diritti dell’Indagato
Prima dell’interrogatorio, il Pubblico Ministero deve informare l’indagato dei seguenti diritti (art. 64 c.p.p.):
- Diritto alla presenza del difensore: l’indagato deve essere assistito da un avvocato di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.
- Diritto al silenzio: l’indagato può decidere di non rispondere senza che ciò possa essere usato contro di lui.
- Diritto a non autoaccusarsi: l’indagato non può essere costretto a confessare.
- Diritto a essere informato dei fatti contestati.
Se questi diritti non vengono rispettati, le dichiarazioni rese dall’indagato possono essere inutilizzabili nel processo.
- Modalità dell’Interrogatorio
L’interrogatorio può avvenire spontaneamente o su convocazione del PM.
2.1. Convocazione e Notifica
- Il Pubblico Ministero può convocare l’indagato mediante invito a presentarsi, notificato dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria.
- Se l’indagato è in stato di custodia cautelare, l’interrogatorio avviene nel luogo di detenzione.
2.2. Svolgimento
- Il PM formula le domande direttamente all’indagato.
- Il difensore può assistere all’interrogatorio e chiedere integrazioni.
- Le dichiarazioni vengono verbalizzate e possono essere firmate dall’indagato.
Se l’interrogatorio riguarda reati gravi o se c’è il rischio di alterazione delle prove, il PM può videoregistrare l’interrogatorio per garantirne l’autenticità.
- Obbligo o Facoltà di Rispondere
- L’indagato non è obbligato a rispondere e può avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Se decide di rispondere, tutto ciò che afferma potrà essere utilizzato nel processo.
- Differenza tra Interrogatorio del PM e della Polizia Giudiziaria
| Aspetto | Interrogatorio della Polizia Giudiziaria | Interrogatorio del Pubblico Ministero |
| Autorità che lo conduce | Polizia Giudiziaria | Pubblico Ministero |
| Obbligo della presenza del difensore | Non sempre obbligatorio | Sempre obbligatorio |
| Finalità | Raccolta di informazioni per le indagini | Valutazione degli elementi probatori e preparazione dell’accusa |
| Effetto sulle dichiarazioni | Possono essere contestate nel processo | Dichiarazioni più rilevanti ai fini processuali |
- Rilevanza Processuale dell’Interrogatorio
Le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero:
- Possono essere utilizzate nel processo.
- Se contenenti elementi di autoaccusa, devono essere valutate con attenzione dal difensore.
- Se l’indagato cambia versione in aula, il PM può contestargli le dichiarazioni rese in precedenza.
- Strategie Difensive Durante l’Interrogatorio
Il difensore deve:
- Valutare se consigliare all’indagato di rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Assicurarsi che le domande siano poste nel rispetto della legge.
- Verificare che il verbale riporti fedelmente le dichiarazioni dell’indagato.
Hai bisogno di ulteriori chiarimenti o di un approfondimento su qualche punto specifico?
CASSAZIONE ARRESTO IN FLAGRANZ A
La Corte di Cassazione, in tema di arresto in flagranza, ha più volte chiarito i principi fondamentali che regolano questa misura, ribadendo i limiti e i criteri di legittimità. Di seguito, analizziamo i principali aspetti relativi alla giurisprudenza della Cassazione sull’argomento.
- Cos’è l’Arresto in Flagranza?
L’arresto in flagranza è una misura precautelare che consente alle forze dell’ordine di privare della libertà una persona colta mentre sta commettendo un reato o immediatamente dopo averlo commesso.
Il Codice di Procedura Penale (artt. 380-381 c.p.p.) distingue due tipi di arresto in flagranza:
- Flagranza propria: quando la persona viene sorpresa mentre sta commettendo il reato o subito dopo.
- Flagranza impropria (quasi flagranza): quando la persona viene inseguita o trovata con elementi che dimostrano il reato appena commesso.
- Condizioni di Legittimità dell’Arresto
La Cassazione ha chiarito che per essere legittimo, l’arresto in flagranza deve rispettare alcuni principi fondamentali:
2.1. Requisiti della Flagranza
- Contemporaneità temporale: L’arresto è valido solo se l’indagato viene sorpreso durante o subito dopo il reato.
- Evidenza del reato: Deve esserci un legame chiaro tra l’azione dell’indagato e il reato contestato.
- Elementi inequivocabili: Non basta il sospetto, ma devono esserci prove concrete della responsabilità.
2.2. Arresto Obbligatorio e Facoltativo
- Arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.): Per reati gravi (es. omicidio, rapina, violenza sessuale), la Polizia Giudiziaria deve arrestare il colpevole.
- Arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.): Per reati meno gravi (es. furto semplice, lesioni lievi), la Polizia può arrestare, valutando la pericolosità del soggetto.
2.3. Tempestività e Immediatezza
La Cassazione ha ribadito che il concetto di flagranza non può essere esteso arbitrariamente nel tempo. Un arresto eseguito dopo un lasso di tempo significativo dall’azione criminosa non è più un arresto in flagranza, ma deve seguire le regole della custodia cautelare.
- Giurisprudenza della Cassazione sull’Arresto in Flagranza
3.1. Cassazione e Illegittimità dell’Arresto Ritardato
Secondo la Cassazione, l’arresto non è valido se:
- Viene eseguito dopo che è trascorso un tempo eccessivo dal reato (es. dopo alcune ore o giorni).
- L’indagato viene identificato solo successivamente tramite indagini e non colto sul fatto (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 36959/2018).
- L’elemento della flagranza si basa solo su indizi e non su una constatazione immediata (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 50995/2019).
3.2. Cassazione e Arresto in Quasi Flagranza
La Cassazione ha affermato che l’inseguimento dell’indagato è un elemento essenziale per la validità della quasi flagranza:
- Se l’inseguimento è interrotto o avviene con un ritardo ingiustificato, l’arresto è illegittimo (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 2925/2020).
- Deve esserci una connessione diretta e ininterrotta tra il reato e l’arresto (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 48512/2017).
3.3. Cassazione e Violazione delle Garanzie Difensive
- Se l’arresto viene effettuato senza garantire il diritto alla presenza del difensore, l’interrogatorio dell’arrestato può essere annullato (Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 21837/2019).
- Se la flagranza è contestata e l’arrestato non viene portato tempestivamente davanti al giudice per la convalida, l’arresto è nullo (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 44024/2021).
- Convalida dell’Arresto e Possibili Esiti
Dopo l’arresto, la persona deve essere presentata al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) per la convalida entro 48 ore.
Il GIP può:
- Convalidare l’arresto e applicare una misura cautelare (se sussistono gravi indizi e pericolo di fuga).
- Convalidare l’arresto e liberare l’indagato (se non ci sono esigenze cautelari).
- Non convalidare l’arresto (se l’arresto è illegittimo, la persona viene immediatamente liberata).
- Conseguenze dell’Arresto Illegittimo
Se la Cassazione accerta che un arresto in flagranza è illegittimo, può disporre:
- L’annullamento della misura cautelare se ancora in corso.
- L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona arrestata.
- Una possibile responsabilità disciplinare o risarcitoria per gli agenti che hanno eseguito l’arresto in violazione delle norme.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’arresto in flagranza non può essere utilizzato in modo arbitrario. È necessario che la persona sia colta sul fatto o immediatamente dopo con elementi chiari e inequivocabili. Qualsiasi deviazione da questi principi può portare all’annullamento dell’arresto e alla sua invalidazione processuale.
Certamente, posso fornirti un commento dettagliato sulla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 36959 del 2018. Tuttavia, è importante notare che la sentenza n. 36959 è stata emessa nel 2021 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e riguarda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Contesto Giuridico:
La questione centrale affrontata nella sentenza riguarda l’obbligo di motivazione del periculum in mora nei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, del Codice di Procedura Penale. In particolare, si discute se sia necessario motivare specificamente il pericolo nel ritardo dell’adozione della misura cautelare quando il sequestro è finalizzato alla confisca facoltativa di beni considerati profitto del reato.
Principio di Diritto Stabilito:
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
“Il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.”
Analisi della Decisione:
La Corte ha sottolineato che, anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario fornire una motivazione specifica riguardante il periculum in mora. Ciò significa che il giudice deve indicare le ragioni per cui è indispensabile procedere al sequestro del bene prima della conclusione del processo, evidenziando il rischio concreto che, senza tale misura, il bene possa essere disperso, alterato o sottratto, compromettendo così l’efficacia della futura confisca.
Tuttavia, la Corte ha precisato che esistono eccezioni a questo obbligo di motivazione dettagliata. In particolare, quando si tratta di beni la cui stessa fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (ad esempio, armi illegali o sostanze stupefacenti), la pericolosità è intrinseca al bene stesso. In tali casi, la motivazione può limitarsi a indicare che il bene rientra tra quelli la cui detenzione è vietata dalla legge, rendendo superflua una dettagliata esposizione del periculum in mora.
Implicazioni Pratiche:
Questa pronuncia delle Sezioni Unite ha importanti ricadute pratiche. I giudici che dispongono un sequestro preventivo finalizzato alla confisca devono prestare particolare attenzione alla motivazione del periculum in mora, assicurandosi di fornire una giustificazione adeguata e concreta della necessità della misura cautelare. Solo in presenza di beni intrinsecamente pericolosi, come quelli la cui detenzione è di per sé illecita, è possibile adottare una motivazione semplificata.
Conclusione:
La sentenza n. 36959 del 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce l’obbligo di motivazione del periculum in mora nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, distinguendo tra beni intrinsecamente pericolosi e altri tipi di beni. Questa distinzione guida i giudici nell’adozione di misure cautelari reali, garantendo un equilibrio tra l’efficacia dell’azione penale e la tutela dei diritti fondamentali degli individui.
CONFISCA PENALE ARTICOLI
La confisca penale è una misura di sicurezza patrimoniale prevista dal Codice Penale italiano che comporta l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte dello Stato, di determinati beni legati a un reato. La disciplina generale della confisca è contenuta nell’articolo 240 del Codice Penale.
Articolo 240 del Codice Penale: Confisca
L’articolo 240 distingue tra confisca facoltativa e obbligatoria:
- Confisca Facoltativa: Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
- Confisca Obbligatoria: Il giudice deve sempre ordinare la confisca:
- Delle cose che costituiscono il prezzo del reato.
- Delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni relative alla confisca facoltativa e alla confisca obbligatoria del prezzo del reato non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. Per quanto riguarda le cose menzionate al punto 2, la confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Altre Disposizioni Rilevanti sulla Confisca
Oltre all’articolo 240, il Codice Penale prevede altre forme di confisca in specifici ambiti:
- Articolo 322-ter: In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, corruzione o concussione), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile confiscare tali beni, si procede alla confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.
- Articolo 603-bis.2: In materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati o destinati a commettere il reato, nonché dei proventi o profitti derivanti dallo stesso. Se la confisca diretta non è possibile, è disposta la confisca per equivalente su altri beni di cui il reo ha la disponibilità.
Tipologie di Confisca
La confisca può essere classificata in diverse tipologie:
- Confisca Facoltativa: Disposta a discrezione del giudice, riguarda beni utilizzati per commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto.
- Confisca Obbligatoria: Imposta dalla legge, riguarda beni che costituiscono il prezzo del reato o la cui detenzione è di per sé illecita.
- Confisca per Equivalente: Quando non è possibile confiscare direttamente il bene che costituisce il profitto o il prezzo del reato, si procede alla confisca di altri beni di valore corrispondente appartenenti al reo.
- Confisca Allargata: Prevista per specifici reati, consente di confiscare beni il cui valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal condannato, presumendo che siano frutto di attività illecite.
Natura Giuridica della Confisca
La confisca è generalmente considerata una misura di sicurezza patrimoniale, volta a prevenire la commissione di ulteriori reati eliminando dalla disponibilità del reo beni pericolosi o illeciti. Tuttavia, alcune forme di confisca, come la confisca per equivalente, presentano caratteristiche afflittive assimilabili a una sanzione penale.
Tutela dei Terzi
La legge prevede tutele per i terzi in buona fede che vantano diritti sui beni oggetto di confisca. Ad esempio, la confisca non si applica se il bene appartiene a una persona estranea al reato che non era a conoscenza dell’uso illecito del bene e non poteva prevederlo. Inoltre, in alcuni casi, è possibile per il terzo proporre opposizione alla confisca per far valere i propri diritti.
Per approfondire ulteriormente la disciplina della confisca penale, si consiglia di consultare direttamente gli articoli del Codice Penale sopra menzionati e la giurisprudenza correlata.




 mancanza, da un difensore d’ufficio.
mancanza, da un difensore d’ufficio.