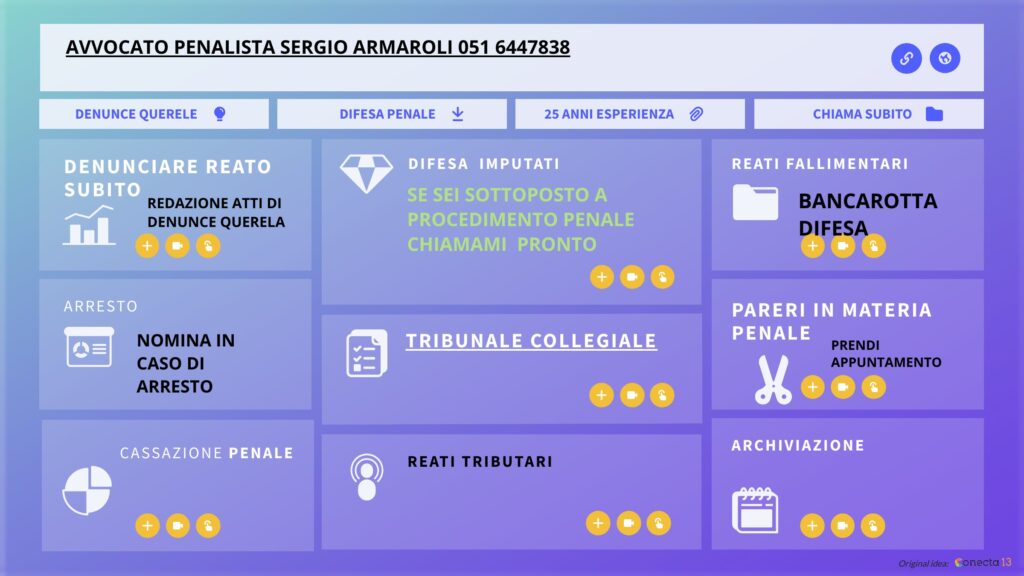Il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato è previsto dall’art. 316-ter del codice penale italiano. Questo reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Il reato si configura quando una persona, per sé o per altri, percepisce indebitamente una erogazione pubblica, ovvero un contributo, un finanziamento, un mutuo agevolato, un reddito di cittadinanza, un reddito di emergenza, o altre prestazioni sociali agevolate, al di fuori dei casi previsti dalla legge o in misura superiore a quanto previsto.
Perché si configuri il reato, è necessario che sussistano i seguenti elementi:
- Percezione indebita: la persona deve aver percepito una erogazione pubblica, ovvero un contributo, un finanziamento, un mutuo agevolato, un reddito di cittadinanza, un reddito di emergenza, o altre prestazioni sociali agevolate.
- Erogazione pubblica: la erogazione deve essere erogata da un ente pubblico, ovvero da un soggetto pubblico o privato che agisce per conto dello Stato o di un altro ente pubblico.
- Carattere indebito della percezione: la percezione deve essere avvenuta indebitamente, ovvero al di fuori dei casi previsti dalla legge o in misura superiore a quanto previsto.
Il reato può essere commesso sia da una persona fisica che da una persona giuridica.
Esempi di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato:
- Una persona che presenta false dichiarazioni per ottenere un reddito di cittadinanza.
- Una società che presenta false fatture per ottenere un finanziamento agevolato.
- Un pubblico ufficiale che utilizza la sua posizione per ottenere un mutuo agevolato a condizioni più vantaggiose.
Sanzioni:
La pena per l’indebita percezione di erogazione in danno dello Stato è la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Inoltre, la persona che ha commesso il reato è obbligata a restituire l’erogazione percepita indebitamente.
Cass. pen. n. 28683/2010
Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la responsabilità dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001 qualora anche solo l’ultima erogazione sia stata percepita dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28683 del 21 luglio 2010)Cass. pen. n. 23628/2010
Il reato di abuso di ufficio commesso da pubblico ufficiale (nella specie, funzionario dell’INPS) al fine di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, allorché il vantaggio altrui sia consistito nel beneficio di arretrati pensionistici non spettanti e fatti ottenere mediante artifici e raggiri (nella specie attraverso interventi sui sistemi informatici idonei ad attribuire a soggetti diversi dagli aventi diritto l’erogazione del trattamento di pensione).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23628 del 18 giugno 2010)Cass. pen. n. 4839/2010
Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell’ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente “gonfiato”, anche quando sia previsto a carico del richiedente l’obbligo di successiva rendicontazione sull’effettivo impiego delle somme percepite.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4839 del 4 febbraio 2010)Cass. pen. n. 35968/2009
Integra il reato di cui all’art. 10 quater D.L.vo n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.L.vo n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale. (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui all’art. 10 quater D.L.vo n. 74 del 2000, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35968 del 16 settembre 2009)Cass. pen. n. 26256/2007
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l’art. 640 quater).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26256 del 6 luglio 2007)Cass. pen. n. 6825/2007
È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall’estero e quindi tenuta a riscuotere, all’atto della rivendita, l’IVA dovuta per l’importazione, per versarla quindi all’Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6825 del 16 febbraio 2007)Cass. pen. n. 5656/2007
Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l’uno si connota per l’evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l’altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l’assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l’applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5656 del 8 febbraio 2007)Cass. pen. n. 40226/2006
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può materialmente concorrere con il reato di frode fiscale, con il quale è ordinariamente in rapporto di specialità, nel caso in cui, in concreto, le condotte siano solo parzialmente sovrapponibili, siano diversi i soggetti passivi tratti in errore e siano diversi i patrimoni aggrediti, e specificamente nel caso in cui un soggetto ottenga, attraverso l’artificio di utilizzare fatture passive per operazioni inesistenti, oltre ad un indebito rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e/o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, anche la concessione di un contributo pubblico per l’acquisto di beni strumentali.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40226 del 6 dicembre 2006)È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all’importo dei ricavi nell’anno 2018 ed al danno arrecato all’attività di impresa dall’emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell’Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. (In motivazione la Corte ha chiarito che la prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di “altre erogazioni… comunque denominate”, in considerazione della sua gratuità e del suo ruolo di presupposto fondamentale ai fini dell’erogazione del finanziamento). (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ MANTOVA, 08/05/2021)
Va subito evidenziato che la vicenda fattuale, non oggetto di rilievi difensivi, perche’ ritenuta pacificamente conforme a quella descritta nell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero, riportata testualmente nell’ordinanza impugnata (pp. 2-3), si inserisce nel contesto di una operazione di finanziamento erogato in data 6 maggio 2020 dalla (OMISSIS), filiale di (OMISSIS), sulla base della richiesta della parte mutuataria avanzata in data 23 aprile 2020 ai sensi del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, articolo 13, lettera m), (c.d. decreto liquidita’), convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 5 giugno 2020, che prevede l’ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo 5 Unico bancario (Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni. Prima di entrare nel merito della questione giova ricordare che la normativa introdotta dal citato decreto n. 23 del 2020, nel quadro del piu’ ampio intervento volto a dare sostegno alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, ha ampliato e facilitato le condizioni di ammissione alla garanzia offerta dal Fondo Centrale di garanzia delle Piccole e Medie Imprese, istituito dalla L. n. 662 del 23 dicembre 1996, (ex articolo 2, comma 100, lettera a). E’ bene premettere che il Fondo Centrale di Garanzia PMI fa ora parte del piu’ generale Sistema Nazionale di Garanzia, istituito dalla L. 27 dicembre 2013, n. 143, per l’utilizzo piu’ efficiente delle risorse pubbliche e delle garanzie dello Stato, ed e’ amministrato ai sensi della L. n. 143 del 2013, articolo 1, comma 48, lettera a), da un Consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Con pubblica gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5 serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010) la gestione del Fondo e’ stata poi affidata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituto da cinque banche, la cui mandataria e’ la (OMISSIS) S.p.a., con sede in (OMISSIS). Non vi e’, quindi, dubbio, alla stregua di tali indicazioni, che la garanzia del Fondo, concessa alle condizioni di legge per agevolare la erogazione di finanziamenti ai soggetti che possono beneficiarne, si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e piu’ in generale ai soggetti ammessi al detto beneficio. Per quanto qui di interesse in relazione al caso da cui origina la questione, l’articolo 13 del decreto cit., come risultante dalla legge di conversione, ha definito un meccanismo in 6 deroga al funzionamento ordinario del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni, associazioni professionali, e societa’ tra professionisti che risultino danneggiate dall’emergenza Covid-19, innalzando l’importo massimo garantito per singola impresa, con determinazione di un plafond di 5.000.000,00 di Euro e sancendo la gratuita’ della garanzia. Va, poi, evidenziato che la lettera m) dell’articolo 13 cit. per la operativita’ della garanzia pubblica richiede che i finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione del credito ed abbiano una durata fino a 120 mesi. Si deve rilevare, altresi’, che in sede di conversione del decreto sono stati modificati i parametri di riferimento per l’erogazione della garanzia, essendo stato stabilito che le operazioni finanziarie non possano eccedere, in ogni caso, un importo, alternativamente, pari a il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, o pari al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019, e comunque detto importo non puo’ mai essere superiore a 30.000,00 Euro. Il testo originario del decreto legge, in vigore al momento dei fatti per cui si procede, prevedeva invece che l’importo del finanziamento non fosse superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000,00 Euro, fermo restando il riferimento temporale all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, ad altra idonea documentazione, sempre ed in ogni caso da dimostrare mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, articolo 47. Va rimarcato, per le importanti conseguenze che da cio’ discendono in punto di qualificazione del reato, che la procedura di erogazione della garanzia in sede di conversione e’ rimasta immutata rispetto a quella regolata dal decreto legge, poiche’ i dati commisurativi dell’importo della garanzia riferiti all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda ovvero, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, deve risultare mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 articolo 47, e sempre mediante autocertificazione, resa nelle stesse forme, deve risultare il rapporto causa-effetto tra la pandemia e il danno lamentato dall’impresa. Da notare anche che l’assunzione della garanzia da parte del Fondo centrale e’ automatica e che l’erogazione del finanziamento e’ subordinata alla verifica formale del possesso dei 7 requisiti, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, senza che sia necessario, per il soggetto finanziatore, attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo. La normativa richiamata dispone, infatti, testualmente che “in favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e’ concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”. 2. Tanto cio’ premesso, si puo’ ora affrontare la questione della qualificazione del fatto posta dal ricorrente, anticipando, da subito e per maggiore chiarezza espositiva, che si condividono pienamente le conclusioni cui sono pervenuti, prima il G.i.p. e poi Tribunale, in merito all’inquadramento del fatto nella fattispecie prevista dall’articolo 316-ter c.p.. Posto che la garanzia a carico del Fondo di garanzia PMI si distingue nettamente per struttura negoziale dalle altre agevolazioni che comportano l’impiego di risorse pubbliche in cui e’ lo Stato il diretto finanziatore che eroga il prestito, e fermo restando che in materia penale vigono i principi di tassativita’ e determinatezza della incriminazione che vietano applicazioni analogiche della norma penale in malam partem, il tema centrale che qui deve essere affrontato e’ quello della delimitazione dell’ambito di rilevanza penale segnato dagli articoli 316-ter e 640-bis c.p., con riferimento al carattere chiuso o aperto della elencazione contenuta nelle predette norme con riguardo alla descrizione delle forme di assistenza ed agevolazione economica che lo Stato concede e/o eroga a beneficio di determinati soggetti alle condizioni richieste per il conseguimento di detti benefici a carico della finanza pubblica. Come e’ noto, entrambe tali fattispecie fanno riferimento alla nozione di “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” e si distinguono tra loro per aspetti che riguardano non gia’ la tipologia delle erogazioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunita’ Europee, che sono obiettivamente identiche, ma soltanto per le modalita’ con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari Il problematico discrimine tra le due predette fattispecie incriminatrici ha trovato oramai una definitiva e condivisa soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, che, risolvendo il contrasto delineatosi nella 8 giurisprudenza dell’epoca, relativo alla riconducibilita’ o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale o previdenziale – nel caso scrutinato, il reddito minimo di inserimento – alle previsioni di cui agli articoli 316-ter e 640-bis c.p., hanno analizzato le differenze tra gli elementi costitutivi di tali delitti. La sentenza Carchivi ha chiarito che l’ambito di applicazione dell’articolo 316-ter c.p., resta circoscritto a situazioni marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso serbato dal richiedente ovvero di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale. In epoca successiva la giurisprudenza ha confermato tale linea esegetica, evidenziando come il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si differenzi da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche finalizzata al conseguimento delle stesse, previsto dall’articolo 640-bis c.p., per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato il soggetto erogatore e’ chiamato esclusivamente ad operare una presa d’atto dell’esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un’autonoma attivita’ di accertamento (tra le molte, Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036). 3. Quanto ai rapporti con il delitto di truffa ai danni dello Stato, sempre alle Sezioni Unite Carchivi si deve l’avere posto in evidenza che l’articolo 640-bis c.p., prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in rapporto di specialita’ con la circostanza aggravante di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, in continuita’ con quanto affermato da Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi Rv. 221663. Dalla comparazione tra le due norme – come efficacemente osservato risulta immediatamente evidente che esse presentino un ambito applicativo assimilabile a due cerchi concentrici, con la conseguenza che la circostanza prevista dall’articolo 640-bis c.p., si applica solo quando la truffa abbia comportato l’indebita concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ Europee. 9 Il rapporto tra l’articolo 316-ter e l’articolo 640 bis, come chiarito sempre dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite, si risolve nel descrivere un ulteriore e residuale ambito di applicazione dell’articolo 316-ter, una sorta di terzo cerchio concentrico di minore ampiezza, che punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, conseguita senza l’induzione in errore. 4. Questo Collegio ritiene di dovere aderire all’impostazione ermeneutica consolidata del carattere residuale e sussidiario del reato di cui all’articolo 316-ter c.p., nonche’ alla definizione di “erogazione pubblica” fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha chiarito, anche con pronunce del suo piu’ autorevole consesso, la portata e ribadito la piena rispondenza al principio di determinatezza della fattispecie e di conoscibilita’ e prevedibilita’ della incriminazione penale. Entrambe le fattispecie incriminatrici in esame fanno, infatti, uso di una locuzione volutamente “aperta” e di vasta portata semantica costituita da “altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. Gia’ in epoca risalente la giurisprudenza di legittimita’ ha qualificato in termini ampi come contributi e sovvenzioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, mentre ha ricondotto nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosita’ attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155). Piu’ recentemente e’ stato affermato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell’articolo 316-ter c.p., l’indebito conseguimento di un voucher da un ente pubblico (nella specie, per la frequentazione di un corso di formazione), atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria (Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950). Argomenti a favore della tesi che qui si propugna sono desumibili, innanzitutto, dalla gia’ citata pronuncia delle Sezioni Unite, Carchivi, n. 16568 del 19/04/2007 che ha evidenziato come ” il riferimento sia dell’articolo 316-ter sia dell’articolo 640-bis c.p., a “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” e’ tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non 10 desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l’intervento pubblico, anche Europeo, allo scopo di orientare o sostenere le piu’ diverse attivita’ economiche e sociali “. Sulla stessa linea ermeneutica si pone poi anche la sentenza delle Sezioni Unite, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104. In tale arresto la Corte ha ritenuto che integri il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione dell’agente in ordine alle proprie condizioni reddituali, resa allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e ospedaliere (ticket). La decisione muove dalla considerazione che, in una prospettiva ermeneutica coerente con la ratio della norma incriminatrice, non sia coessenziale alla nozione di contributo in genere e di ogni altro atto ad esso assimilato, una elargizione in danaro, denotando il contributo il conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalita’ pubblica, che abbia prodotto quale profitto il risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa. Ed invero, nell’ambito della nozione onnicomprensiva di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, devono ritenersi comprese – ad avviso delle Sezioni Unite – non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo, ma anche l’esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perche’ anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che ricade a carico della comunita’, con correlato danno per l’ente pubblico. 5. Infine, giova evidenziare come anche in riferimento ad altri istituti del diritto commerciale che rinviano alla nozione di finanziamento pubblico, si sono registrate pronunce delle Sezioni civili di questa Corte che si sono espresse a favore di una lettura tesa a recuperare la prestazione di garanzia alle misure finanziarie di agevolazione statale. In particolare, vanno ricordate le sentenze in tema di riconoscimento dei privilegi ex Decreto Legislativo n.123 del 31 marzo 1998, sui crediti del Fondo PMI conseguenti all’escussione della garanzia, che hanno esteso la natura di credito privilegiato attraverso una interpretazione piu’ ampia della locuzione “finanziamenti”, cosi’ da ricomprendere tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attivita’ produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, i quali possono consistere secondo l’articolo 7 del Decreto Legislativo cit. – in credito d’imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato; cio’ in 11 considerazione della unitaria direzione finalistica che, impiegando risorse pubbliche, lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l’aiuto finanziario alle imprese, in funzione di salvaguardia del loro tessuto economico produttivo. Conclusione estesa, quindi, anche alle garanzie concesse dallo Stato ed avvalorata dal rilievo che l’assunzione di una garanzia personale ” non presenta, per qualita’, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro ” (Sez. Civ., 1, n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683; Sez. civ., 1, n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, in adesione a quanto affermato anche dalla Procura generale di questa Corte di legittimita’ nelle proprie conclusioni scritte, che la prestazione di una garanzia fideiussoria proprio perche’ costituisce di norma una prestazione onerosa, se rilasciata gratuitamente e costituendo anche fondamentale presupposto per l’erogazione del finanziamento, rappresenta di per se’ sola un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si avvale cosi’ da essere riconducibile alla nozione di “altre erogazioni…comunque denominate” contenuta sia nell’articolo 316-ter che nell’articolo 640-bis c.p.. La clausola di chiusura adoperata nelle norme incriminatrici e’ un chiaro indice della volonta’ legislativa di prescindere dal nomen iuris del vantaggio economico goduto dal privato e di attribuire rilievo a qualsiasi “erogazione” da cui il destinatario tragga un tale vantaggio a spese dello Stato. Non si tratta, in conclusione, di avvalorare una interpretazione analogica o estensiva della norma incriminatrice che porti ad ampliare arbitrariamente la sfera della rilevanza penale a discapito del penalmente lecito, ma di delimitarne l’ambito di operativita’ attraverso la definizione dell’oggetto della sua fattispecie, in rapporto, da un lato, al discrimine con la piu’ generica e tendenzialmente omnicomprensiva fattispecie della truffa punita dall’articolo 640, c.p., e dall’altro lato, in coerenza alla chiara finalita’ del legislatore di non lasciare impunite condotte latamente fraudolente ogniqualvolta difetti l’elemento decettivo proprio della truffa. 7. L’orientamento che si propugna non pone fondati problemi di legittimita’ costituzionale, poiche’ la tecnica legislativa utilizzata non e’ connotata da una inaccettabile genericita’ descrittiva. 12 La giurisprudenza costituzionale ha gia’ affermato – sia pure con riferimento ad altre figure di reato – che l’uso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici” non viola il parametro costituzione di determinatezza quando al giudice sia comunque consentito, attraverso la complessiva descrizione del fatto e avuto riguardo alle finalita’ dell’incriminazione e al piu’ ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca, di stabilire il significato dell’elemento che isolatamente considerato non sia specifico, e al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo (Corte Cost., sent. n. 327 del 2008, in tema di disastro ambientale; in materia di immigrazione clandestina, sent. n. 5 del 2004 e sent. n. 34 del 1995). Inoltre, va sottolineato che detto orientamento e’ stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due succitate sentenze Carchivi e Pizzuto, ed appare in definitiva coerente con la genesi del reato di induzione indebita, introdotto ad opera della L. n. 300 del 29 settembre 2000, in attuazione degli obblighi di incriminazione previsti dalla Convezione sulla tutela degli interessi finanziari (PIF) delle Comunita’ Europee del 26 luglio 1995, per reprimere gli abusi non fraudolenti posti in essere per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, siccome lesivi degli interessi finanziari dell’Unione

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee
Cass. pen. n. 15487/2021
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture – che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell’agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi – sia con il reato di corruzione, in quanto l’accordo corruttivo, pur non potendo integrare l’induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo. (Fattispecie relativa alla fornitura, mediante subappalti non autorizzati, di conglomerati bituminosi di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sulle cui modalità esecutive, in forza di accordo corruttivo, venivano omesse segnalazioni e controlli). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ REGGIO CALABRIA, 26/06/2020)
.
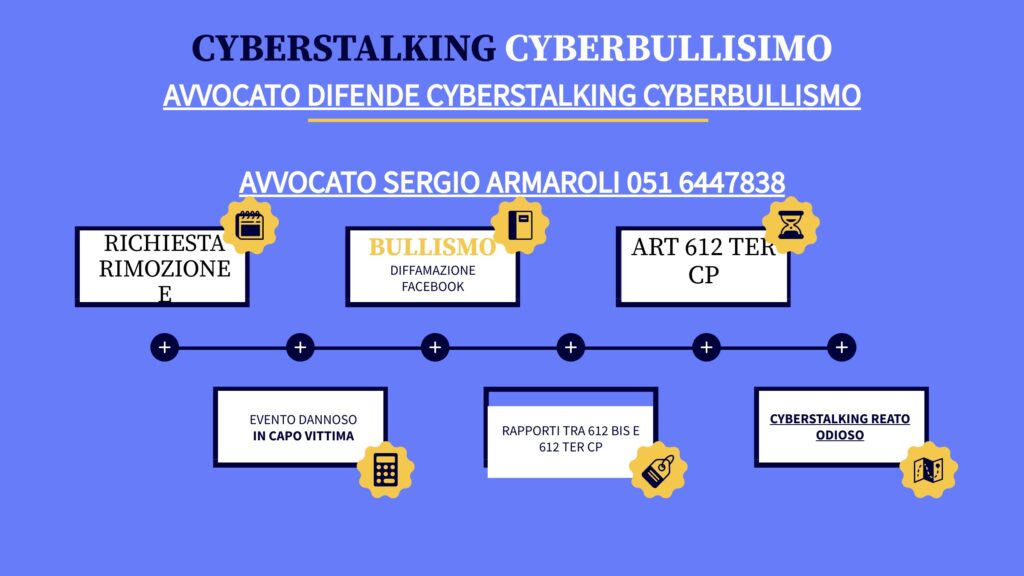
Cass. pen. n. 2125/2021
È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all’importo dei ricavi nell’anno 2018 ed al danno arrecato all’attività di impresa dall’emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell’Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. (In motivazione la Corte ha chiarito che la prestazione della garanzia pubblica va ricondotta nella nozione di “altre erogazioni… comunque denominate”, in considerazione della sua gratuità e del suo ruolo di presupposto fondamentale ai fini dell’erogazione del finanziamento). (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ MANTOVA, 08/05/2021)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2125 del 24 novembre 2021)

Cass. pen. n. 20996/2021
Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., la “memoria di costituzione” depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012)
(Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 20996 del 22 luglio 2021)
Cass. pen. n. 33497/2021
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la condotta del responsabile di una società concessionaria di più emittenti radio-televisive che, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, contravvenendo all’obbligo di separazione contabile in relazione a ciascuna emittente, attesti falsamente la riferibilità di taluni dati essenziali dell’attività d’impresa ad un’emittente anziché all’effettiva (nella specie, il fatturato medio ed il numero dei dipendenti), atteso che la mancata osservanza del suddetto obbligo impedisce l’espletamento dei controlli da parte delle autorità preposte a verificare i requisiti di ogni singola emittente richiedente i contributi. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/12/2020)
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33497 del 28 maggio 2021)
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15487 del 1 febbraio 2021)
Cass. pen. n. 11136/2020
Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o “certificati bianchi”, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed il conseguente evento di danno. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA’ TREVISO, 04/10/2019)
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11136 del 6 marzo 2020)
Cass. pen. n. 12278/2020
In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l’approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 24/09/2018)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12278 del 15 gennaio 2020)
Cass. pen. n. 22192/2019
Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell’alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22192 del 21 maggio 2019)
Cass. pen. n. 40260/2017
Risponde del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e non di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40260 del 5 settembre 2017)